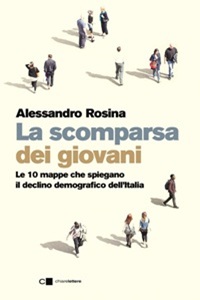Se c’è una costante che attraversa tutte le generazioni e che non è certo diminuita nei giovani di oggi, è il desiderio di contare, di poter fare la differenza, di sentirsi parte attiva di un mondo che cambia e migliora con le loro idee e la loro azione. A cambiare è la realtà con cui si confrontano, le sfide del proprio tempo, le condizioni in cui si trovano, le modalità di partecipazione.
Gli studenti che scendono in piazza in solidarietà alla popolazione di Gaza o che manifestano contro condizioni di vita percepite come ingiuste o contro deficit democratici interni, come nel caso delle proteste in Serbia o in Nepal, non vanno archiviati come episodi isolati ed estemporanei, ma colti come segnali di una tensione profonda che attraversa le nuove generazioni.
Da un lato, questi giovani mostrano di non essere indifferenti rispetto a ciò che accade nel mondo: la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie, di mobilitarsi per valori universali, di manifestare solidarietà oltre i confini nazionali dimostra l’esistenza di un capitale morale e civico che rimane vivo e vitale. D’altro lato, la percezione di non avere reali strumenti per incidere sulle scelte politiche e collettive, come mostrano i dati dell’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo, genera frustrazione e rischia di tradursi in disillusione, sfiducia e ritiro dalla partecipazione pubblica.
Il senso di impotenza non è soltanto il riflesso di un atteggiamento psicologico individuale, ma un effetto di condizioni strutturali che si stanno consolidando. La prima riguarda il processo di “degiovanimento”, ovvero la riduzione del loro peso demografico rispetto alla popolazione anziana. Ciò comporta un indebolimento della forza numerica con cui i giovani possono guadagnare attenzione e farsi sentire sul piano elettorale e nell’agenda politica. La seconda condizione è relativa ai canali tradizionali di rappresentanza: partiti, sindacati e organizzazioni civiche, che storicamente hanno dato voce anche alle nuove generazioni, oggi tendono a intercettarne meno le esigenze, risultando spesso non in piena sintonia con nuovi linguaggi, valori e modalità di azione.
A ciò si aggiunge una terza dimensione, di natura simbolica e culturale. Gli under 25 di oggi sono stati proiettati in una realtà che ha indebolito molti punti fermi considerati acquisiti nel secondo dopoguerra: è tornata una crisi economica di gravità comparabile a quella del 1929, è tornata una pandemia in grado di fermare il mondo, è tornata la guerra nel continente europeo, lo stesso progetto dell’Unione europea è entrato in crisi. Nel frattempo è aumentato il debito pubblico, si è aggravato il riscaldamento globale, la crisi demografica rischia di portare a squilibri insostenibili.
Insomma, il mondo non solo è diventato più complesso e in accelerato mutamento, ma si trova in una fase di permacrisi che rende il futuro una grande incognita.
La conseguenza peggiore di tutto questo è che nei giovani cresca il senso di rassegnazione e impotenza, che porta a togliersi valore e a scivolare nell’insignificanza.
Per quanto negative e problematiche siano le condizioni del presente, il mondo riparte sempre dalle nuove generazioni e può migliorare solo se messe in grado di generare nuovo valore attraverso le loro idee e la loro azione.
Sperimentandosi nella mobilitazione collettiva, i giovani rispondono all’esigenza di inclusione e riconoscimento. Ribadiscono il diritto a esistere come attori rilevanti e non come semplici spettatori dei processi che plasmano il presente e il futuro. Da qui deriva la necessità di pensare a strumenti e spazi di partecipazione più adeguati. Non si tratta soltanto di aprire nuove arene deliberative, ma di ripensare il funzionamento delle istituzioni, dei meccanismi di policy e delle forme di intermediazione sociale in modo da renderle capaci di dialogare con le nuove generazioni. Il punto cruciale è consentire ai giovani di percepire che il loro impegno ha un peso reale: che le scelte quotidiane, l’attivismo civico, la partecipazione ai processi decisionali non sono gesti isolati, ma contribuiscono a orientare le traiettorie collettive.
In altre parole, bisogna rafforzare la connessione positiva tra comportamenti individuali e destino collettivo, tra energia giovanile e trasformazione sociale. Solo in questo modo si può contrastare il rischio di insignificanza e ritiro dal bene comune, e al contrario consentire alle nuove generazioni di farsi motore di rinnovamento democratico.