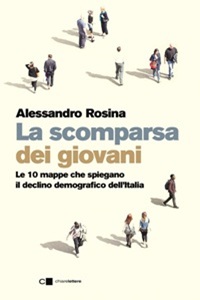ESTRATTO
ALESSANDRO ROSINA — È vero che all’interno delle famiglie sta aumentando la fetta di quelle che vengono chiamate le famiglie unipersonali, cioè chi vive da solo. Ed è una crescita speculare alla discesa delle coppie con figli, cioè della famiglia tradizionale. Le famiglie unipersonali, che erano arrivate a essere oltre il 25% all’inizio di questo secolo, adesso sono più di una su tre. Tra i motivi di questa crescita: l’aumento della popolazione anziana che resta senza coniuge; nelle età centrali c’è l’effetto dello scioglimento delle coppie; e poi c’è la crescita dei single tra i giovani, come conseguenza del fatto che si lascia la famiglia d’origine per cercare opportunità di lavoro. È anche vero che il mercato si sta adattando sempre più alle persone che vivono come single, oggi c’è un’accettazione sociale che legittima la tua scelta; per esempio non esistono più le «zitelle». Poi ci sono alcuni cambiamenti di tipo organizzativo: si diffondono i Lat, Living up together, due persone che vivono in abitazioni diverse e che si percepiscono in una in relazione sentimentale. Questo fa capire anche quanto siamo in una fase in cui la statistica ha difficoltà a misurare quello che accade se continua ad utilizzare categorie superate. Infine, ci sono dei cambiamenti culturali che riguardano gli atteggiamenti e le preferenze: l’aumento dell’individualismo, la riduzione dell’importanza delle norme sociali; l’orientamento a fare scelte in autonomia per la propria realizzazione; l’atteggiamento critico verso la qualità della coppia. Non c’è più un’accettazione incondizionata. E sta succedendo qualcosa di nuovo anche nelle nuove generazioni, dai Millennial (i nati tra il 1982 e il 1996, ndr) in avanti, che sta cambiando ancora con la Gen Z (o Generazione Z, 1997-2012, ndr): ciò che nelle generazioni precedenti si voleva conquistare, cioè che l’unione matrimoniale potesse essere sciolta, che l’autonomia femminile potesse portare a scelte di realizzazione personale; che la valutazione della coppia di qualità, e l’essere single, fosse qualcosa di accettato, è diventato la normalità.
Quindi oggi cos’è la norma?
ALESSANDRO ROSINA — Non è più una coppia che dura per sempre, ma una coppia che può sciogliersi. In Italia il cambiamento rispetto al divorzio è avvenuto anche in tempi più lenti rispetto agli altri Paesi: prima ci volevano 5 anni di separazione per arrivare al divorzio, ora vanno a coincidere. Oggi l’instabilità coniugale si sta avvicinando a quello che si osserva in altri Paesi: oltre un matrimonio su tre si scioglie e la maggioranza delle coppie si forma con un’unione informale anziché con matrimonio. E oltre il 40% dei figli nasce fuori dal matrimonio. Tutti cambiamenti da aggiungere all’aumento naturale della longevità. Poi, a partire dalla Gen Z, c’è tutto l’impatto di internet, dei social, del web 2.0, di Tinder (tra le più celebri App di dating, le app di incontri con cui trovare partner romantici o sessuali, ndr), e l’idea dei legami fluidi, la possibilità di formare relazioni basate su criteri con cui confronti varie opzioni di partner su cui fare la tua scelta, sperimenti… E arriviamo ai giovani che si confidano con ChatGTP.
ALESSANDRO ROSINA — La coppia tradizionale è messa in discussione, ma non per essere superata tout court da una nuova tipologia che si imporrà, e che sarà una non-coppia. Non si impongono tipologie che vanno a sostituire quelle precedenti, si crea piuttosto un’eterogeneità, una maggiore possibilità di vivere le relazioni, e al contempo ci si perde anche nelle scelte possibili, e ci si ritrova in una condizione di incertezza. Ognuno deve trovare i propri equilibri o disequilibri dinamici; non si vuole rinunciare all’investimento su di sé e alla propria crescita personale, ma al contempo diventa un impoverimento dover rinunciare ai progetti di relazione. Ed è questa la questione su cui le nuove generazioni rischiano di essere spiazzate e di perdersi. Ma al di là della relazione affettiva esclusiva, legata alla monogamia, c’è una condizione di relazione affettiva privilegiata che nessuno vuole perdere; cioè il sentirsi esseri speciali nei confronti di un’altra persona è valore. Come ben espresso nella canzone “la cura” di Battiato.
Ci sono dati che illustrano questa condizione di incertezza nelle relazioni giovanili?
ALESSANDRO ROSINA — I dati del Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo che abbiamo appena raccolto, e che si riferiscono al 2024, fanno capire come questa condizione della relazione affettiva esclusiva, che si fa fatica a tenere assieme, ma che si vorrebbe costruire, vada poi a ripescare atteggiamenti tradizionalisti. Quando chiediamo ai ragazzi, tra i 18 e i 34 anni, se considerano mai accettabili i seguenti comportamenti, vediamo che gli stereotipi di genere alla fine permangono proprio per la difficoltà di riuscire a declinare in maniera nuova, e positiva, le relazioni. Quindi: controllare abitualmente il cellulare e l’attività sui social network del o della partner, dicono che è mai accettabile il 47,7% dei maschi e il 61% delle femmine. Geolocalizzare e controllare la posizione del o della partner non è mai accettabile per il 49,6% dei maschi e il 60,5% delle femmine. Vietare al o alla partner di vestirsi in un certo modo è inaccettabile per il 43,5% dei maschi e per il 73,7% delle femmine. Vietare al o alla partner di uscire con chi vuole, lo considerano mai accettabile il 47,1% dei maschi e il 68,9% delle femmine. Ecco, continuano a essere presenti delle forti differenze di genere che vanno ad adottare modelli tradizionali per la difficoltà di trovare nuovi codici per vivere positivamente la coppia e sentirsi soggetto privilegiato nella relazione, senza voler sentire l’altro come ricondotto alle proprie esigenze e a dar sicurezza a sé stesso.
ALESSANDRO ROSINA — C’è anche un forte legame col titolo di studio: più è alto, più le donne si sentono autonome e pretendono di essere indipendenti.
ALESSANDRO ROSINA — Quello che cambia tra le generazioni è il riconoscimento, in teoria, che le differenze di genere andrebbero superate. Però poi, in concreto, nei dati, tornano a emergere.
ALESSANDRO ROSINA — Sul fatto che qualsiasi cosa che può fare un maschio dovrebbe poterla farla una femmina, c’è un riconoscimento accettato. Ma sul piano della coppia c’è qualcosa che poi non funziona e schiaccia in difesa rispetto alle proprie paure, ai propri timori rispetto al poter perdere il legame che fa sentire unici e speciali.
ALESSANDRO ROSINA — Non dobbiamo avere la visione distorta della condizione delle famiglie ritraendole con una fotografia statica, perché va colta come qualcosa che evolve nella vita delle persone. È vero che le famiglie tradizionali, cioè le coppie con figli, ora sono la minoranza. Ma se andiamo a vedere quante sono le persone che nel corso della loro vita hanno formato una coppia con figli, diventano la maggioranza. È importante recuperare quello che si diceva sull’eterogeneità: persone diverse in età diverse, in fasi della vita diverse, possono fare scelte diverse e sempre di più le faranno. È questo che sta mutando rispetto a situazioni più standard.
ALESSANDRO ROSINA — Quando c’erano percorsi più standardizzati, universali, anche le politiche si rivolgevano a qualcosa che era più standard. Ma quando aumenta l’eterogeneità, la capacità di produrre delle politiche che riconoscano obbligazioni e diritti e che proteggano da condizioni di fragilità diventa una sfida elevata. E se non si riesce a interpretare la realtà che cambia, il rischio è che scelte individuali legittime, possano esporre a ricadute negative con malessere e disagio sociale, e in Italia questo rischio è maggiore perché abbiamo una minor capacità di accompagnare il cambiamento con politiche adeguate.