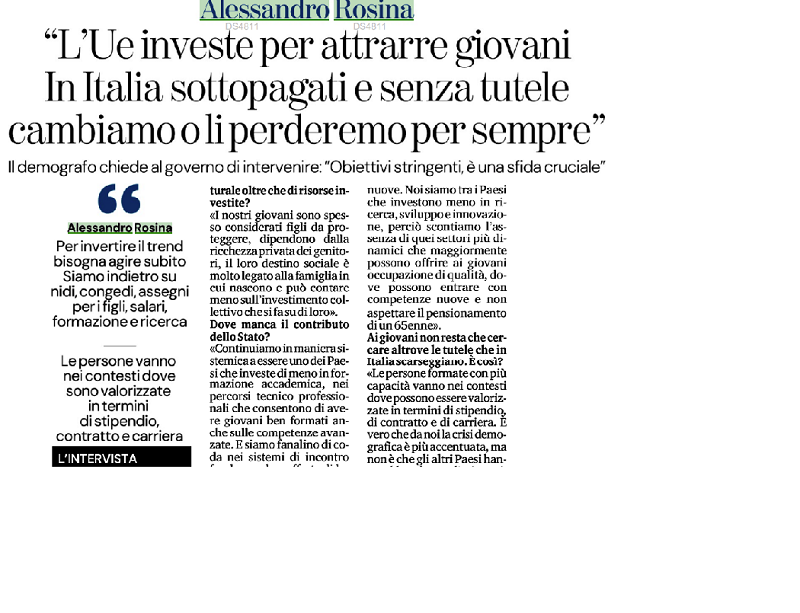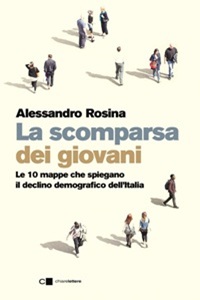Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica dell’Università Cattolica di Milano, non è certo stupito dal fatto che 100 mila ragazzi italiani abbiano lasciato l’Italia nell’ultimo decennio: «Non abbiamo investito sulla loro formazione, sulle politiche attive, sulla ricerca, sulla valorizzazione del capitale umano all’interno delle aziende. Non stiamo consentendo ai giovani di sentirsi parte attiva di una società che cresce e che migliora con loro. Gli altri Paesi, invece, risultano più attrattivi».
«I nostri giovani sono spesso considerati figli da proteggere, dipendono dalla ricchezza privata dei genitori, il loro destino sociale è molto legato alla famiglia in cui nascono e può contare meno sull’investimento collettivo che si fa sudi loro». Dove manca il contributo dello Stato? «Continuiamo in maniera sistemica a essere uno dei Paesi che investe di meno in formazione accademica, nei percorsi tecnico professionali che consentono di avere giovani ben formati anche sulle competenze avanzate. E siamo fanalino di coda nei sistemi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Il risultato è che ci troviamo con una delle più alte percentuali di neet, cioè di giovani che non studiano e non lavorano». Non pensa che ci sia anche un problema salariale? «Certo, troppe imprese utilizzano i giovani come manodopera a basso costo anziché far leva sul capitale umano per essere più produttive e competitive. Questo ci porta bassa crescita e basso sviluppo». Il problema deriva dalla composizione del nostro tessuto produttivo che è fatto di micro e piccole imprese? «Non può essere un alibi dire che le piccole imprese non hanno le caratteristiche e la capacità per offrire, ad esempio, welfare aziendale. Bisogna incentivarle nella valorizzazione dei giovani e delle donne e negli investimenti in formazione continua e conciliazione, sperimentando soluzioni nuove. Noi siamo tra i Paesi che investono meno in ricerca, sviluppo e innovazione, perciò scontiamo l’assenza di quei settori più dinamici che maggiormente possono offrire ai giovani occupazione di qualità, dove possono entrare con competenze nuove e non aspettare il pensionamento di un 65enne». Ai giovani non resta che cercare altrove le tutele che in Italia scarseggiano. È così? «Le persone formate con più capacità vanno nei contesti dove possono essere valorizzate in termini di stipendio, di contratto e di carriera. È vero che da noi la crisi demografica è più accentuata, ma non è che gli altri Paesi hanno abbondanza di giovani. La Svezia, la Germania, il Regno Unito hanno anche loro una fecondità inferiore ai due figli per donna e quindi un ricambio generazionale insufficiente nel mondo del lavoro». L’Italia sta perdendo la competizione per attrarre i giovani migliori? «Le altre economie avanzate sono molto competitive da questo punto di vista, l’Italia rischia di trovarsi sempre più in difficoltà. Se altrove esistono maggiori opportunità, perché restare o tornare in Italia?». Il governo sostiene di aver messo al centro il tema della natalità, lei vede un’inversione di tendenza? «Guardiamo i dati. Non sappiamo neanche se i bonus di quest’anno saranno confermati l’anno prossimo nella manovra finanziaria. La copertura dei nidi continua a essere molto più limitata rispetto agli altri Paesi. Siamo in attesa di vedere se il piano sui servizi per l’infanzia con i fondi del Pnrr riuscirà a recuperare questo gap. Attualmente non c’è un salto di qualità, siamo sempre sotto il 33% di copertura della fascia 0-2 anni dei nidi, quando l’obiettivo dell’Europa era quello di arrivare al 33% nel 2010. Ora il nuovo target è il 45%, entro il 2030». Per quanto riguarda il sostegno economico ai figli? «Per invertire il trend della denatalità è necessario portare le politiche italiane al meglio delle esperienze europee. In Germania, per ogni figlio, indipendentemente dal reddito dei genitori, c’è un assegno di 250 euro al mese mentre in Italia l’assegno unico universale continua ad avere una base molto bassa. Quanto ai congedi di paternità, un altro tema fondamentale della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all’interno delle famiglie, l’Italia si è adeguata al minimo, cioè ai dieci giorni di paternità pagati al 100%. In altri Paesi europei la paternità è di tre mesi». Cosa occorre fare nel breve periodo? «Darsi obiettivi stringenti anno per anno. Ad esempio, portare al 2028 un livello di copertura dei nidi al 45%. Oppure rafforzare l’assegno unico o equiparare la paternità alla maternità entro al 2030. Stesso discorso sui salari e sul contributo per pagare l’affitto. Se c’è questo impegno un giovane può decidere di rimane in Italia perché il Paese diventa credibile e ha un orizzonte».