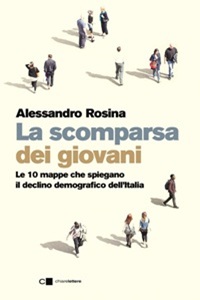La demografia ha recentemente conquistato attenzione nel dibattito pubblico italiano. Purtroppo, va detto, in grave ritardo rispetto sia agli altri paesi con cui ci confrontiamo, sia ai tempi necessari per rispondere in modo adeguato alle sfide che pone. I contenuti delle audizioni svolte nelle scorse settimane dalla “Commissione parlamentare sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto” consente di farsi un’idea di quanto i vari soggetti istituzionali e gli enti di ricerca nazionali considerino particolarmente grave la situazione in cui ci siamo posti. Può essere, allora, utile chiarire alcuni punti affinché il dibattito possa davvero portare ad un confronto costruttivo e non rimanere bloccato su letture contrapposte parziali.
Un primo punto riguarda il fatto che il problema non è in sé l’aumento dell’aspettativa di vita. E’ questa una sfida positiva che solo un paese confuso e incapace di gestire i cambiamenti del proprio tempo può trasformare in un fatto negativo. Quando diventa effettivamente un problema? Quando non si mettono le persone nelle condizioni di costruire basi solide di una lunga vita attiva e in salute, ma anche quando si creano accentuati squilibri quantitativi tra generazioni a causa del continuo crollo delle nascite. I paesi in crisi demografica sono quelli più deboli su questi due aspetti.
Un secondo punto da chiarire è il fatto che nella parte finale della transizione demografica tutti i paesi tendono a scivolare sotto il livello di equilibrio nel rapporto tra generazioni, ovvero sotto i due figli per donna. Non tutti si trovano, però, nella stessa situazione. Le attuali donne francesi e svedesi arrivate a 45 anni presentano un numero medio di figli superiore a 1,8, questo significa che le future coorti che arriveranno a 45 anni entro la metà del secolo rimarranno sostanzialmente solide. La fecondità delle 45enni italiane è invece attorno a 1,35, con conseguenti coorti in entrata nell’età lavorativa che tendono a ridursi di circa un terzo. Attuare politiche efficaci, quindi, fa la differenza, ma è anche vero che esse vanno rinnovate e riadattate a esigenze e aspettative che mutano nel tempo.
L’accentuata diminuzione italiana della fecondità è senz’altro la causa dei nostri maggiori squilibri nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni. E’ però altrettanto vero, qui sta il terzo punto da precisare, che non è più di per sé sufficiente un suo aumento per risolvere tali squilibri. Ciò per due motivi. Il primo è che la persistenza della natalità su livelli bassi è arrivata ad erodere la popolazione nell’età in cui si hanno figli. Il secondo motivo è il fatto che un aumento consistente delle nascite nei prossimi anni porterebbe a un più solido ricambio generazionale nel mercato del lavoro dal 2050 in poi. La ripresa della natalità è quindi condizione necessaria per non avere squilibri ancora più accentuati nei prossimi decenni, ma non consente da sola di dare risposte alle esigenze attuali. L’immigrazione adeguatamente gestita e regolata fornisce un doppio beneficio. Il primo è quello di compensare la riduzione della popolazione in età lavorativa andando direttamente incontro ai fabbisogni di aziende e organizzazioni in vari settori. Il secondo è di rafforzare la popolazione in età riproduttiva, contribuendo così a risollevare le nascite. Ma la stessa immigrazione non basta. Se non migliorano le politiche familiari, di genere e generazionali, il nostro paese rimarrà poco accogliente e attrattivo: gli immigrati più dinamici e qualificati tenderanno a scegliere altri paesi o a considerare l’Italia solo come un paese di passaggio.
Nel complesso, il concetto che deve essere chiaro è che ciò che serve per far invertire la tendenza delle nascite, tende a far aumentare anche lo sviluppo economico del paese, il benessere delle famiglie e la sostenibilità sociale. Il prodotto interno lordo dipende da tre elementi: il numero di persone in età attiva, il tasso di occupazione, la produttività. Tutti questi fattori sono legati in modo interdipendente con i meccanismi delle dinamiche demografiche.
Ridurre il divario tra numero di figli desiderati e realizzati assieme ad adeguati flussi migratori consente al contingente di persone in età attiva di non indebolirsi troppo nel presente e nel prossimo futuro. Anche il tasso di occupazione ha buoni margini di miglioramento a causa del nostro sottoutilizzo del capitale umano giovanile e femminile. Ma migliorando la transizione scuola-lavoro e il bilanciamento vita-lavoro, si mette chi desidera avere figli in migliori condizioni per averli. Interventi in questa direzione consentono, quindi, di agire in modo concomitante sia sigli effetti che sulle cause degli squilibri demografici, con benefici sia nel breve che nel medio periodo.
Va aggiunto che miglior ingresso e valorizzazione dei giovani nel mondo del lavoro e migliore conciliazione, come molti studi evidenziano, tendono a favorire ingaggio e clima aziendale, alimentando un possibile circuito virtuoso tra produttività e stipendi. In questo modo il paese diventa anche più attrattivo, ovvero più capace di far arrivare e trattenere chi cerca opportunità di piena valorizzazione.
Infine, prolungare la vita attiva ha un impatto sull’occupazione, ma aumenta la produttività solo se si investe sulla formazione continua e sulle modalità di collaborazione tra generazioni, combinando positivamente esperienza, competenze e nuove tecnologie.
E’ quindi evidente che solo un approccio che sappia inserire la questione demografica in modo sistemico nel contesto delle politiche di sviluppo competitivo del paese, può portare a solidi effetti positivi. L’obiettivo non è, però, di per sé quello di far crescere il pil e la natalità. E’ rendere l’Italia un paese in cui si può: lavorare bene, crescere bene sin dall’infanzia, vivere bene in tutte le fasi della vita, scegliere di rimanere, integrare positivamente esperienze e provenienze diverse. Puntiamo la barra in questa direzione e ci troveremo anche con più benessere economico e più figli desiderati.