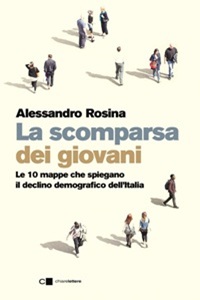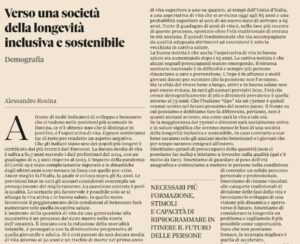
A fronte di molti indicatori di sviluppo e benessere che ci vedono nelle posizioni più scomode in Europa, ce n’è almeno uno che si distingue in positivo, è l’aspettativa di vita. Eppure sembriamo far di tutto per renderlo un aspetto negativo. Che gli italiani siano uno dei popoli più longevi è certificato dai più recenti dati Eurostat. La durata media di vita è salita a 81,7 anni secondo i dati preliminari del 2024, con un guadagno di o,3 anni rispetto al 2023. L’impatto della pandemia di Covid-19 è stato completamente superato e le dinamiche degli ultimi anni sono tornate in linea con quelle pre-crisi. Ancor meglio fa l’Italia, la quale si colloca sopra gli 84 anni. Le previsioni Istat in tutti gli scenari considerati contempla un proseguimento del miglioramento. La questione centrale è però la qualità.
Lo scenario più favorevole è possibile solo se si allunga la vita attiva e in buona salute. In quello meno favorevole il peggioramento delle condizioni di benessere farà aumentare solo quella in cattiva salute. L’aumento della quantità di vita da una generazione alla successiva è un processo del tutto nuovo nella storia dell’umanità. È iniziato con la riduzione della mortalità infantile, è proseguito con la diminuzione progressiva di quella giovanile e adulta. Si è così passati da una durata media di vita attorno ai 30 anni e un rischio di morte nel primo anno di vita superiore a uno su quattro, ai tempi dell’Unità d’Italia, a una aspettativa di vita che si avvicina oggi agli 85 anni e una probabilità superiore al 90% di un nuovo nato di arrivare a 65 anni. Tutto il guadagno di anni di vita è, nella fase più recente di questo processo, spostato oltre l’età tradizionale di entrata in età anziana. È quindi fondamentale che sia accompagnato da qualità adeguata altrimenti ad estendersi è solo la vecchiaia in cattiva salute. La buona notizia è che anche l’aspettativa di vita in buona salute sta aumentando dopo i 65 anni. La cattiva notizia è che alcuni segnali preoccupanti stanno emergendo. Il sistema sanitario nazionale è in difficoltà e sempre più persone rinunciano a cure e prevenzione. L’Inps è in affanno e molti giovani danno per scontato che la pensione non l’avranno. Ma la sfida del vivere bene a lungo, attivi e in buona salute non può essere evitata. In tutti gli scenari previsivi Istat, l’età che cresce demograficamente di più e diventerà prevalente è quella attorno ai 75 anni. Che l’italiano “tipo” sia un 75enne è quindi oramai scritto nel futuro prossimo del nostro paese. Il fronte su cui possiamo e dobbiamo fare la differenza, pertanto, non è quanti anziani avremo, ma come sarà la vita a tale età. Se la maggioranza dei 75enni e dintorni sarà socialmente attiva e in salute significa che avremo messo le basi di una società della longevità inclusiva e sostenibile. In caso contrario a star bene saranno solo gli anziani molto benestanti e i giovani che per tempo saranno emigrati all’estero. Smettiamo quindi di preoccuparci della quantità (non ci possiamo far nulla) e iniziamo a investire sulla qualità (qui c’è molto da fare). Smettiamo di guardare al peso dell’età anagrafica e cominciamo a mettere le persone nella condizione di costruire un solido percorso personale e professionale. Smettiamo di rimane vincolati alle categorie tradizionali di divisione delle fasi della vita e favoriamo lo sviluppo di una visione più dinamica e aperta verso il futuro. Smettiamo di considerare la longevità un problema e cogliamola il più possibile come opportunità. Dato che non possiamo frenare, la strategia migliore è quella di accelerare. Dante si colloca «nel mezzo del cammin di nostra vita» a 35 anni, coerentemente con l’idea che una vita libera dai rischi di morte evitabili possa arrivare fino ai 70 anni. Pochi, a quei tempi, giungevano a tale traguardo. Oggi viviamo in un mondo in cui è considerato normale arrivarci. Ma siamo andati anche oltre. Finora, però, “oltre” è stato inteso come bonus di anni in più, per i singoli, da spendere dopo la piena fase adulta e come sovraccarico sul sistema di welfare, rimasto impostato su fasi della vita tradizionali e su una struttura della popolazione fatta a piramide (tanti giovani e pochi anziani). La constatazione che cambia la struttura quantitativa della popolazione non basta, per trovare nuove soluzioni serve ripensare le fasi della vita. I 35 anni del mondo statico del passato equivalgono ai 50-55 anni di oggi, e i 70 anni agli 85-90, con tendenza ad espandersi ulteriormente. Arrivare a so anni in piena forma è qualcosa che diamo oggi per scontato. Giunti a tale età si aprono altri 35 anni di vita attesa. Questo significa, di fatto, trovarsi davanti una seconda vita, non un bonus di anni aggiunti alla prima. Finora la tattica prevalente è stata quella di dilatare: si rimane più a lungo nella famiglia di origine, si diventa autonomi più tardi, si rinvia la formazione di una propria famiglia e la nascita di un figlio, si prolunga l’attività lavorativa. Ma se l’aspettativa di vita continua ad estendersi dobbiamo prima di tutto avere un progetto di come arricchirla personalmente oltre che renderla sostenibile collettivamente. Per arrivare a 75 anni attivi e in buona salute sono necessari maggiore formazione, maggiori stimoli, maggior capacità di riprogrammare in itinere il proprio futuro. Dobbiamo, allora, prendere in considerazione anche la possibilità di rinascere a so anni; ovvero, sulla base dell’esperienza lavorativa, sociale, familiare della prima vita, rilanciare e impostare una seconda vita con davanti un ciclo di almeno 25 anni in piena forma. Si potrebbe prevedere la possibilità di fermarsi per formarsi e riqualificarsi dai 50 ai 55 anni, fare il bilancio sul proprio percorso passato, ridefinire desideri e obiettivi, fruire di consulenza e orientamento per un secondo ciclo professionale. Questa seconda vita apre anche a rilancio e cambiamenti nella sfera affettiva e familiare. Le giovani donne di oggi, verosimilmente, si troveranno a 60 anni in condizioni simili alle 35enni dei primi decenni del secondo dopoguerra. Avere figli (anche) dopo i 5o anni sarà sempre più possibile, non solo per chi congela gli ovuli da giovane. È vero che mancano politiche adeguate per mitigare l’impatto dei processi in atto, ma dobbiamo ancor più pensare in modo diverso alla direzione da dare a tali processi, tenendo assieme qualità e sostenibilità.