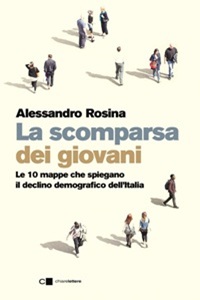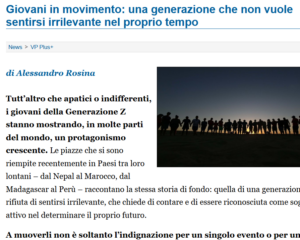
Le piazze che si sono riempite recentemente in Paesi tra loro lontani – dal Nepal al Marocco, dal Madagascar al Perù – raccontano la stessa storia di fondo: quella di una generazione che rifiuta di sentirsi irrilevante, che chiede di contare e di essere riconosciuta come soggetto attivo nel determinare il proprio futuro.
A muoverli non è soltanto l’indignazione per un singolo evento o per una specifica ingiustizia. È la percezione di vivere in un mondo che non li rappresenta, governato da una classe dirigente senza visione, più impegnata a conservare se stessa che a costruire orizzonti condivisi. Ovunque emerge la sensazione che il futuro stia prendendo una direzione sbagliata – nelle disuguaglianze, nella corruzione, nella crisi ambientale e nei conflitti – e che chi ha il potere non stia agendo con la responsabilità necessaria verso chi verrà dopo.
Non chiedono soltanto migliori condizioni materiali, ma la possibilità di essere considerati attori rilevanti, capaci di incidere su decisioni che oggi vengono prese altrove. Vogliono contare, contribuire, dare un’impronta a questo secolo che sentono come proprio. La Generazione Z è la prima nata e cresciuta interamente nel XXI secolo, un tempo – come costantemente rilevato dalle ricerche dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo – che sente di voler abitare e arricchire con le proprie idee e la propria sensibilità.
È anche una generazione segnata da una duplice fonte di incertezza: quella globale – legata al clima, ai conflitti, all’impatto delle nuove tecnologie e al futuro del lavoro – e quella locale, legata alle condizioni concrete in cui vive: disoccupazione, salari bassi, servizi carenti, inaffidabilità della politica. A tutto questo i giovani reagiscono cercando di uscire dalla condizione di marginalità in cui si sentono relegati, una condizione che alimenta senso di impotenza e di irrilevanza. La mobilitazione diventa così un modo per ritrovare voce, autostima e senso di efficacia collettiva.