
Dar conto di come sarà la demografia italiana e mondiale tra 160 anni è forse un’operazione meno complessa di quella di chi 160 anni fa, ovvero nel primo decennio dell’Unità d’Italia, si fosse posto l’obiettivo di prevedere la demografia di oggi.

Dar conto di come sarà la demografia italiana e mondiale tra 160 anni è forse un’operazione meno complessa di quella di chi 160 anni fa, ovvero nel primo decennio dell’Unità d’Italia, si fosse posto l’obiettivo di prevedere la demografia di oggi.

Sono molti i prodotti che se improvvisamente sparissero o diventassero sempre meno disponibili metterebbero in crisi un Paese. Per assurdo ipotizziamo di non avere più aerei, o non aver più telefoni, o non aver più computer, o non aver più farmaci da banco, sarebbe certo un disastro ma sopravviveremmo in qualche modo.

Non si sostiene la natalità solo con annunci o interventi ai margini, o ancor peggio accusando i giovani di non aver più i valori di una volta. L’aggravamento della situazione demografica richiede un salto di qualità nelle politiche familiari che non si nota nelle misure incluse nella Legge di Bilancio dell’anno scorso e di quello attuale. Non si tratta solo di un problema italiano, ma il nostro paese sembra tra i meno impegnati ad affrontarlo con il giusto approccio e attraverso solidi interventi strutturali.
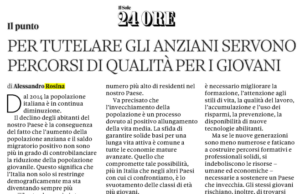
Dal 2014 la popolazione italiana è in continua diminuzione. Il declino degli abitanti del nostro paese è la conseguenza del fatto che l’aumento della popolazione anziana e il saldo migratorio positivo non sono più in grado di controbilanciare la riduzione della popolazione giovanile. Questo significa che l’Italia non solo si restringe demograficamente ma sta diventando sempre più squilibrata al proprio interno a sfavore delle fasce più attive, dinamiche e produttive.
La popolazione residente è complessivamente scesa da 60,3 milioni nel 2014 a meno di 59 milioni oggi. Secondo le previsioni Istat nel 2050 saremo meno di 55 milioni nel 2050, ritornando ai livelli che avevamo nella prima metà degli anni Settanta del secolo scorso. E’ un problema? Quanto è nato il Sistema sanitario nazionale, nel 1978, il numero medio di figli per donna era ancora su livelli che garantivano l’equilibrio nel rapporto tra generazioni (come noto vicino a 2,1 mentre oggi siamo sotto 1,2); l’Italiano “tipo” era un trentenne e gli anziani costituivano una componente relativamente contenuta della popolazione. Da allora al 2050 la fascia tra i 18 e i 34 anni si troverà a ridursi da circa 14 milioni a poco più di 8 milioni, viceversa quella di 75 anni e oltre ad espandersi da circa 2,5 a 11,5 milioni. A metà di questo secolo l’italiano “tipo” sarà un settantacinquenne, ovvero a quell’età corrisponderà il numero più alto di residenti nel nostro Paese.
Va precisato che l’invecchiamento della popolazione è un processo dovuto al positivo allungamento della vita media. La sfida di garantire solide basi per una lunga vita attiva è comune a tutte le economie mature avanzate. Quello che compromette tale possibilità, più in Italia che negli altri paesi con cui ci confrontiamo, è lo svuotamento delle classi di età più giovani.
Come documentato e argomentato nel mio recente libro “La scomparsa dei giovani” (Chiarelettere 2025), non possiamo evitare la crescita delle fasce anziane, quello che possiamo intelligentemente fare è mettere i cittadini nelle condizioni di arrivare a tale età mantenendo benessere e salute. Questo va a favore sia della qualità della vita delle persone sia della sostenibilità del sistema paese. Per investire in tale direzione è necessario migliorare la formazione, l’attenzione agli stili di vita, la qualità del lavoro, l’accumulazione e l’uso dei risparmi, la prevenzione, la disponibilità di nuove tecnologie abilitanti. Ma se le nuove generazioni sono meno numerose e faticano a costruire percorsi formativi e professionali solidi, si indeboliscono le risorse – umane ed economiche – necessarie a sostenere un Paese che invecchia. Gli stessi giovani rischiano, inoltre, di trovarsi con bassi salari e carriere discontinue che portano a rinunciare ad avere figli, ad accumulare insufficienti contributi previdenziali e a rinunciare a una pensione integrativa. Questo vale ancor più per le donne. Non è un caso che aumenti la mobilità dei giovani verso l’estero e a crescere al loro interno sia soprattutto la componente femminile.
E’ quindi evidente che una società della longevità sostenibile ha bisogno di investire sulla qualità. Sia in termini di condizione attiva e salute per la crescente popolazione anziana, sia in termini di formazione e qualità del contributo allo sviluppo economico e dei percorsi professionali delle generazioni più giovani. Utilizzare meglio risorse economiche e tempo, nella dimensione personale e collettiva, è sempre più strategico per continuare a garantire sviluppo e benessere nelle economie mature avanzate.
—
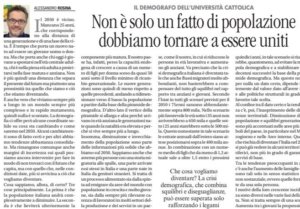
Il 2050 è vicino. Mancano 25 anni, che corrispondono alla distanza di una generazione e di una fase della vita. E’ il tempo che porta un nuovo nato ad essere un giovane uomo o donna. Ma che porta anche chi oggi è giovane a spostarsi nell’età centrale adulta, chi è nella piena età adulta a proiettarsi nella fase matura e anziana. Non è più quindi una distanza che separa il presente dal futuro ma piuttosto una prossimità tra quello che siamo e ciò che stiamo diventando.
E’ anche vero che viviamo sempre più a lungo in un mondo sempre più complesso e in rapido mutamento, quindi nulla è scontato. La demografia ci offre però alcune coordinate solide su cosa sta cambiando e come saremo nel 2050. Alcuni cambiamenti sono di fatto certi e per altri abbiamo tendenze abbastanza consolidate. Ma rimangono comunque anche margini di incertezza sui quali possiamo ancora intervenire per fare in modo di non trovarci con il futuro che capita ma con quello che, nelle condizioni date, più si avvicina a ciò che vogliamo diventare.
Cosa sappiamo, allora, di certo? Tre cose principalmente. La prima è che la popolazione italiana andrà complessivamente a diminuire. La seconda è che lieviterà ulteriormente la componente più matura. Il nostro paese ha, infatti, perso la capacità endogena di crescere a causa di un numero di figli per donna sceso da quasi 50 anni sotto il livello minimo di ricambio generazionale. Le nuove generazioni sono quindi di meno rispetto a quelle precedenti, andando a ridimensionare verso il basso la popolazione a partire dalla base della piramide demografica. D’altro lato il vertice della piramide si allarga e alza perché arrivano in età anziana le generazioni nate quando la natalità era elevata e perché si vive sempre più a lungo.
Insomma, diminuzione e invecchiamento della popolazione sono parte delle informazioni più solide che abbiamo sul 2050.
Sappiamo anche che avremo più persone con una storia migratoria alle spalle, una parte arrivate essi stessi in Italia e una parte nate in Italia da genitori stranieri. Si tratta di un processo alimentato sia dalla spinta ad emigrare da aree del mondo con popolazione in crescita e molto giovane, sia dalla sempre più rilevante carenza di lavoratori in molti settori della produzione e dei servizi in un paese, come il nostro, in cui si riducono le persone in età lavorativa e aumentano gli anziani. Va precisato che la crisi demografica italiana è diventata tale che anche flussi migratori molto abbondanti, non basterebbero a compensare del tutto gli squilibri nel rapporto tra anziani e giovani. Secondo l’Istat in tutti gli scenari previsti per il 2050 i 75enni saranno abbondantemente sopra 800 mila. Nello scenario più favorevole le età sotto i 35 anni non arriverebbero a 650 mila e quelle sotto i 25 anni starebbero sotto le 500 mila. Questo nonostante in tale scenario le entrate annuali dall’estero siano attese posizionarsi sopra le 400 mila annue. In combinazione con un numero medio di figli che da meno di 1,2 attuale sale a oltre 1,5 entro i prossimi quindici anni, in tale scenario si riuscirebbe, quantomeno, ad evitare la trappola demografica e a stabilizzare nei decenni successivi la base della piramide demografica. Ma questo non è per nulla un dato certo, dipende fortemente dal valore dato all’avere figli e alle politiche strutturali in grado di favorire tale scelta.
Al confine tra il dato certo e la tendenza c’è, poi, l’inasprimento delle differenze territoriali. Diminuzione della popolazione e squilibri generazionali sono più accentuati nelle aree più deboli del paese, in particolare nel Mezzogiorno e nelle Aree interne. Quello che rischia di diventare l’Italia nel 2050 si può già vedere in alcuni territori periferici, non più in grado di garantire servizi di base.
Tra le tendenze preoccupanti in atto c’è anche l’aumento delle famiglie che sono tali solo in senso statistico ma non sostanziale, ovvero quelle formate da una sola persona.
I motivi della loro crescente incidenza sono diversi nelle varie fasi della vita. Non si tratta sempre di una scelta. Aumenta tra i giovani la propensione a diventare autonomi, ma spesso le condizioni rispetto ai costi e all’incertezza lavorativa portano a posticipare la formazione di una propria famiglia. In età adulta ci si può ritrovare single dopo il fallimento di una unione. La crescita maggiore e più associata a condizione di fragilità è quella in età anziana. Con l’invecchiamento della popolazione aumenta il numero di persone che si ritrovano sole dopo la perdita del coniuge o di altri congiunti con cui convivevano.
La solitudine è al centro della debolezza nel nostro modo in cu stiamo affrontando i grandi cambiamenti in atto. La popolazione non è un insieme di individui indipendenti, ma va intesa come sistema fatto di storie di vita in relazione tra di loro e in continua tensione con le sfide del proprio tempo. Se si sta indebolendo oggi il nostro essere popolazione non è solo perché la quantità degli abitanti è in diminuzione, ma soprattutto perché ci sentiamo meno uniti, meno parte attiva di un comune destino aperto, di un progetto paese solido da costruire assieme.
La crisi demografica, che combina squilibri e diseguaglianze, può essere superata solo rafforzando i legami: di coppia, tra genitori e figli, tra aree urbane e aree interne, tra nord e sud del paese, tra autoctoni e nuovi arrivati, e di conseguenza tra presente possibile e futuro desiderato.