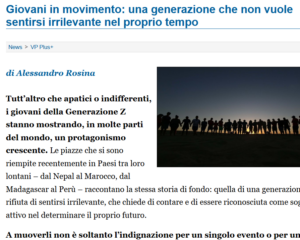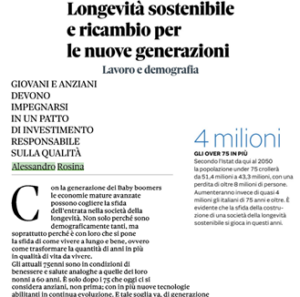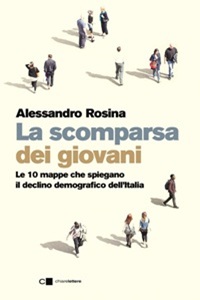L’Italia continua ostinatamente a non essere un Paese per giovani e questo la rende sempre meno anche un Paese per anziani e per tutte le fasi della vita. Tutte le economie mature avanzate si trovano con anziani in aumento, grazie all’estensione della longevità, e con una natalità insufficiente a garantire un adeguato rinnovo generazionale.
Il problema principale non è l’invecchiamento e nemmeno, a ben vedere, la denatalità, ma il processo di degiovanimento. I paesi che vanno verso squilibri accentuati e sempre meno sostenibili, come l‘Italia, non sono quelli con più anziani ma quelli con meno giovani. D’altro canto, l’indebolimento delle nuove generazioni non dipende solo dalle basse nascite ma anche dai flussi di uscita verso l’estero e dalla scarsa capacità di gestire positivamente l’immigrazione. Le stesse nascite, inoltre, possono aumentare solo dove ci sono giovani messi nelle condizioni di realizzare in modo pieno i propri progetti professionali e di vita. La situazione di marginalità sociale ed economica, in cui molti si trovano, contribuisce alla crescita di sfiducia ed espone al rischio di demotivazione, che poi porta a non votare (astensionismo) o a votare con le gambe (diventando Expat).
Serve allora far arrivare ai giovani il messaggio chiaro e forte che – tanto più per il fatto di essere demograficamente di meno – il sistema paese darà ancor più attenzione alle loro esigenze e istanze. Che investirà ancor più sulla loro formazione e sulle loro opportunità. Che chi studia e si impegna, indipendentemente dalle origini, troverà strumenti adeguati per dare il meglio di sé in Italia.
Questo impegno non va però preso per i giovani, ma con i giovani e per il Paese. Non può, quindi, basarsi su rassicurazioni generiche ma richiede la definizione di un nuovo patto generazionale.
Ci sono (almeno) cinque questioni centrali che vanno esplicitamente affrontate nel nuovo patto.
La prima è quella della transizione demografica, a cui corrisponde un mutamento inedito del rapporto quantitativo tra generazioni. A fronte dell’aumento della spesa per pensioni, assistenza e cura della crescente popolazione anziana, quali garanzie ha oggi un giovane che il Paese in cui vive non si troverà ad indebolire le risorse per la formazione, le politiche abitative, gli strumenti di conciliazione tra vita e lavoro?
Il secondo punto riguarda i mutamenti all’interno del mercato del lavoro in combinazione con i cambiamenti demografici. Essere di meno non implica necessariamente trovare maggiori opportunità e maggiore valorizzazione. L’Italia rischia di rimanere vincolata in un percorso di basso sviluppo se oltre al necessario potenziamento della formazione non migliorano anche i sistemi di incontro efficace tra domanda e offerta, gli stipendi e la qualità del lavoro in generale. Se queste condizioni i giovani non le troveranno in Italia andranno sempre più a cercarle altrove. Quale impegno strutturale è in grado di prendere il sistema paese per andare in tale direzione a regime, anche oltre le risorse di Next Generation Ue?
Se non si imbocca un solido sentiero di crescita peggiorerà ulteriormente anche il debito pubblico. Qui sta il terzo punto da rinegoziare nel patto generazionale. Già oggi l’Italia scarica sulle nuove generazioni un indebitamento tra i peggiori al mondo. Come ha ricordato il Governatore di Banca d’Italia, siamo l’unico paese in Europa con interessi sul debito che bruciano l’equivalente della spesa in istruzione. Quale impegno a ridurlo nei prossimi anni? Quali obiettivi misurabili con quali modalità e quali risorse?
Il quarto punto riguarda la spesa in Ricerca, sviluppo e innovazione. Continuiamo ad essere tra le economie mature avanzate che meno investono su tale voce. Questo ha ricadute negative sulla competitività del sistema economico e sulla capacità di adattarsi alle sfide globali. Limita lo sviluppo dei settori più dinamici e competitivi che creano nuove opportunità di lavoro e consentono alle idee dei giovani di diventare nuovi prodotti e servizi che allargano il mercato.
Infine, il quinto punto è quello del peso sulle scelte collettive. La transizione demografica sta producendo uno sbilanciamento dell’elettorato a sfavore delle nuove generazioni. Per contenere questo indebolimento è necessario migliorare i meccanismi di coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali. Serve però anche una collettività che riconosca e supporti le istanze delle nuove generazioni. In generale, come inglobare meglio – in coerenza con l’approccio dello sviluppo sostenibile – il benessere futuro nelle scelte del presente?
La ridefinizione stessa del patto generazionale è pienamente inserita in tale prospettiva. Una rinegoziazione a partire da un confronto aperto, che abbia come base condivisa l’incontro tra quello che le nuove generazioni vorrebbero poter esser e fare (in coerenza con le sfide del proprio tempo) e quello di cui ha bisogno il Paese (con le sue specificità) per rafforzare i propri processi di sviluppo e benessere.