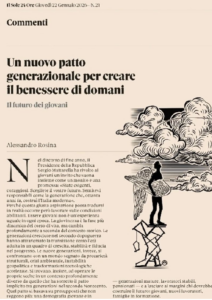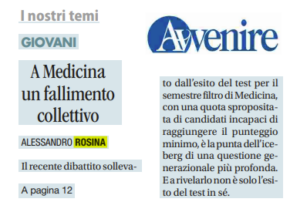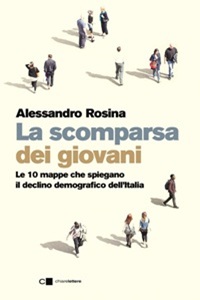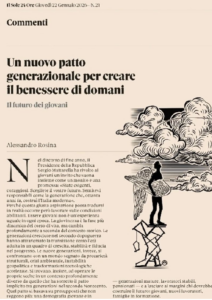
Nel discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto ai giovani un invito che suona insieme come un monito e una promessa: “Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l’Italia moderna”.
Perché questa giusta aspirazione possa tradursi in realtà occorre però lavorare sulle condizioni abilitanti. Essere giovani non è un’esperienza uguale in ogni epoca. La giovinezza è la fase più dinamica del corso di vita, ma cambia profondamente a seconda del contesto storico. Le generazioni cresciute nel secondo dopoguerra hanno attraversato la transizione verso l’età adulta in un quadro di crescita, stabilità e fiducia nel progresso. Le nuove generazioni, invece, si confrontano con un mondo segnato da precarietà strutturali, crisi ambientale, instabilità geopolitica e trasformazioni tecnologiche accelerate. Si trovano, inoltre, ad operare le proprie scelte in un contesto profondamente diverso da quello che ha sorretto il patto implicito tra generazioni nel secondo Novecento. Quel patto si basava su presupposti che non reggono più: una demografia giovane e in espansione, un debito pubblico contenuto, un rapporto favorevole tra popolazione attiva e inattiva, un mercato del lavoro capace di assorbire rapidamente i nuovi ingressi e di costruire una solida previdenza.
In pochi decenni, l’Italia è passata da una società giovane e in crescita a una società longeva e in contrazione demografica, in cui aumentano gli anziani e diminuiscono i giovani. Questo mutamento strutturale non è stato accompagnato da un adeguato ripensamento di istituzioni, politiche e cultura collettiva. Il risultato è un patto generazionale sbilanciato, che tende a proteggere chi è già dentro il sistema — generazioni mature, lavoratori stabili, pensionati — e a lasciare ai margini chi dovrebbe costruire il futuro: giovani, nuovi lavoratori, famiglie in formazione.
Questo squilibrio produce una duplice ingiustizia. È intergenerazionale, perché ai giovani vengono offerte meno opportunità di quelle necessarie per contribuire in modo qualificato allo sviluppo del Paese. Ed è intragenerazionale, perché le disuguaglianze di partenza si amplificano nel tempo, penalizzando soprattutto chi dispone di minori risorse familiari, territoriali e relazionali. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: sfiducia, disimpegno, astensionismo, oppure “voto con le gambe” attraverso l’emigrazione.
Eppure, come ha ricordato il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta nel suo discorso di inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Messina, l’Italia ha bisogno di riorientare le proprie strategie di sviluppo, mettendo al centro solida formazione e piena valorizzazione delle nuove generazioni. Non si tratta di contrapporre giovani e anziani, ma di riconoscere che la condizione giovanile di oggi anticipa la struttura sociale di domani.
L’equità tra generazioni non è, quindi, un tema astratto né solo etico. È una questione centrale per il benessere collettivo, la competitività economica e la sostenibilità sociale. In un Paese in cui si vive più a lungo ma con meno giovani, non basta redistribuire risorse in modo statico. Occorre ridefinire le condizioni di funzionamento dinamico del sistema.
Un Paese equo non è quello che protegge i giovani come soggetti deboli, ma quello che li abilita come protagonisti. L’equità generazionale ha due dimensioni inseparabili: una correttiva, che riduce gli svantaggi accumulati, e una abilitante, che crea le condizioni perché le nuove generazioni possano sviluppare le proprie potenzialità. Questo secondo aspetto è ancora più importante e urgente in un mondo attraversato da transizioni demografica, digitale, ecologica e valoriale, che in modo combinato plasmano il senso del loro essere e fare nel mondo. Il rischio, altrimenti, è che i giovani diventino una minoranza non solo demografica ed elettorale, ma anche sociale e politica, incapace di incidere sulle scelte collettive.
Ridefinire il patto generazionale non significa mettere in discussione il contributo delle generazioni più mature. Al contrario, un nuovo patto deve fondarsi su reciprocità e corresponsabilità. Chi ha beneficiato del passato va riconosciuto per il ruolo svolto, ma deve anche rendere possibile ai giovani di costruire un futuro solido a partire dal presente. Questo implica uno spostamento dello sguardo: dal benessere passato da conservare al benessere futuro da abilitare. Significa anche spostare il baricentro culturale e produttivo del Paese dal XX al XXI secolo, trasformando la maggiore longevità in una risorsa condivisa e la minore numerosità dei giovani in una leva di qualità, capace di portare innovazione, competenze avanzate e nuove sensibilità nei processi di sviluppo.
Solo in questo quadro l’invito ai giovani a essere protagonisti diventa credibile. Una società che chiede ai giovani di assumersi responsabilità deve, allo stesso tempo, metterli concretamente in condizioni di esercitarle.