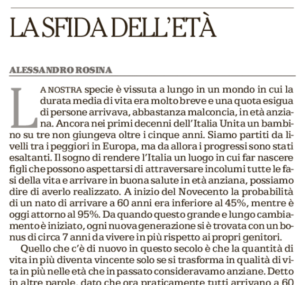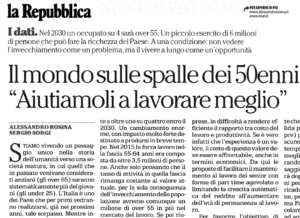Rispondere alle sfide della longevità e all’aumento dei senior presenti nelle organizzazioni è importante e lo si ottiene non solo spostando in avanti l’età pensionabile ma attraverso un effettivo miglioramento delle condizioni di una soddisfacente, efficace e produttiva lunga vita attiva. L’Italia è tra i paesi che hanno posticipato maggiormente l’età alla pensione ma è anche fortemente in ritardo rispetto allo stimolo e al supporto di politiche aziendali di valorizzazione dei lavoratori senior, in un quadro di collaborazione tra generazioni.
A conferma di ciò, le organizzazioni che hanno predisposto o stanno predisponendo politiche e programmi per valorizzare e gestire in modo virtuoso questa popolazione, se pure stanno crescendo di numero, rimangono, nel panorama italiano, molto poche.
In questo contesto, per favorire una maggiore attenzione delle organizzazioni alla valorizzazione dei lavoratori over55 e ad un loro impiego produttivo, diventa essenziale comprendere quali azioni gestionali e quali politiche sono necessarie.
La presenza sempre più massiccia di lavoratori maturi nelle aziende e nelle organizzazioni è fuori discussione. L’occupazione in età matura è la componente cresciuta maggiormente in Italia negli ultimi decenni. Secondo le rilevazioni Istat il tasso di occupazione nella fascia 50-64 ha superato il 45% nel 2006, il 50% nel 2012, per arrivare nel 2017 a sfiorare il 60%. Al contrario, nella fascia 25-34 il tasso è sceso nello stesso periodo da oltre il 70% a valori attorno al 60%. Questo significa che oggi in Italia l’incidenza dell’occupazione in età 50-64 è analoga a quella della fascia 25-34. I valori assoluti sono però diversi, come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione attiva: pari a circa 7,5 milioni nella fascia più matura contro poco più di 4 milioni nella fascia più giovane (si sale a circa 5 milioni considerando tutta la fascia 15-34 anni).
L’attenzione all’ageing da parte delle organizzazioni, d’altro canto, varia fortemente a fronte del numero di senior impiegati.
Aziende che contano tra le proprie risorse umane solo il 2 o il 3% di over55 ovviamente tendono a non considerare il fenomeno; quelle che impiegano centinaia o migliaia di senior e annoverano percentuali più alte di over55 tra i propri dipendenti, si trovano invece a gestire un segmento di popolazione con caratteristiche ed esigenze nuove. Per non dire di quelle organizzazioni – e sono un numero crescente – che prospettano di avere a breve una popolazione aziendale over50 superiore al 50% del totale dei dipendenti e che non possono quindi che considerare strategico l’occuparsene in modo dedicato.
Le organizzazioni più esposte al fenomeno stanno iniziando a prenderne consapevolezza e in qualche caso stanno avviando riflessioni e programmi per capire come gestire adeguatamente questa popolazione e come valorizzarla. Ad esempio, è possibile per un’azienda prevedere mirate iniziative di welfare rivolte alla popolazione lavorativa più anziana ? O soluzioni di organizzazione del lavoro, soprattutto quello manuale, che tengano conto delle esigenze specifiche di chi è avanti nell’età? O programmi in cui i senior sono impiegati in ruoli di mentori, di tutor, di trasmettitori di know how e di cultura aziendale? O ancora, team e progetti dove lavorano insieme giovani e senior che si abituano a lavorare assieme?
Alcune organizzazioni già si stanno cimentando in questi territori, la maggioranza ancora no.
Osservatorio Senior, insieme ad un gruppo di organizzazioni-pilota (ATM, Engie, Istituto Auxologico Italiano, Pirelli, Sanofi), nel corso del 2017 ha sviluppato, con il progetto Silver Value, un sistema di indicatori gestionali attraverso cui riconoscere le organizzazioni che effettivamente valorizzano e gestiscono in modo virtuoso gli over55 al lavoro.
La partecipazione al progetto Silver Value dal 2018 è aperta a tutte le organizzazioni che intendono adottare il metodo, partecipare alla rete e confrontarsi sulle informazioni raccolte e sulle iniziative sviluppate.
L’obiettivo generale che fa da sfondo al progetto è il seguente: “Riconoscere e dar visibilità a strategie organizzative e pratiche aziendali che favoriscono una lunga, produttiva e appagante vita attiva, valorizzando capacità e competenze proprie delle varie fasi della vita lavorativa, in un contesto positivo di collaborazione tra dipendenti giovani e maturi”.
In base al metodo “Silver Value” sono considerate virtuose, nella valorizzazione e gestione dei Senior, le organizzazioni che:
• gestiscono gli over55 in modo non discriminatorio
• gestiscono gli over55 con politiche e programmi dedicati (programmi per la salute, soluzioni di organizzazione del lavoro, soluzioni per la gestione flessibile del tempo, ecc)
• sanno valorizzare gli over55 per le capacità, esperienze e potenzialità che possiedono
• sanno valorizzare le differenze tra generazioni
• sanno preparare all’ageing le proprie risorse umane lungo il corso della vita lavorativa.
Nel corso del 2017 è stato identificato, insieme alle organizzazioni che hanno partecipato al gruppo di lavoro di sviluppo del metodo, un set di indicatori rappresentativi delle cinque dimensioni sopra indicate ed è stata verificata la loro misurabilità in base alle correnti pratiche organizzative.
Per ciascun indicatore, a fronte di una prima rilevazione, si è anche stabilito quali sono i target a cui tendere per essere considerate organizzazioni che gestiscono virtuosamente i senior e più in generale le condizioni per una lunga vita attiva (in tutte le sue fasi).
Il sistema Silver Value prevede una auto-misurazione su base annuale con riferimento a questi indicatori, in modo da verificare la rispondenza delle scelte gestionali e politiche con le buone pratiche in materia di gestione e valorizzazione dei senior. Favorisce inoltre un confronto costruttivo tra realtà che condividono l’importanza strategica di migliorare la qualità della presenza e la produttività dei senior nei luoghi di lavoro.
Scritto in collaborazione con Enrico Oggioni, Fondatore di osservatoriosenior.it