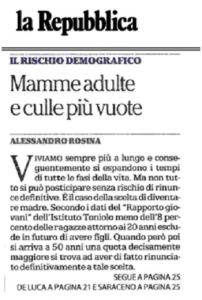C’è stata una fase nella storia di questo paese in cui tra crescita economica, welfare e demografia si è innescato un circuito virtuoso che ha portato al rialzo le condizioni di benessere materiale e di fiducia sociale. E’ stato il periodo che ha visto protagonista la generazione entrata in età adulta nel periodo della ricostruzione e nel corso del quale si è socializzata la generazione dei baby boomers.
Quel modello sociale e di sviluppo oggi non esiste più e uno dei motivi per cui economia e demografia inciampano l’una sull’altra, anziché spingersi a vicenda, va attribuito ad un welfare allo stesso tempo inadeguato e superato.
Quel sistema di protezione sociale era basato quasi esclusivamente sull’azione pubblica, con un approccio prevalentemente assistenzialistico e risarcitorio. Se oggi non funziona più, sia nel difendere da vecchi rischi che nel prevenire i nuovi, non è solo per i costi diventati insostenibili, ma ancor più per il fatto che le rigide risposte fornite dall’alto sono sempre meno in grado di dare una risposta completa ed efficace, in sintonia con l’evoluzione della domanda dal basso.
A questa inefficienza si è risposto, nel nostro paese, più tagliando la spesa pubblica che innovando l’azione sociale. Ma i bisogni non sono certo diminuiti. Le trasformazioni demografiche, sociali e del mercato del lavoro hanno fatto emergere nuovi rischi. L’inadeguatezza delle risposte a questi cambiamenti ha portato sia ad un aumento delle disuguaglianze che a una riduzione del benessere complessivo della popolazione. Situazione aggravata dalla crisi che ha fatto crescere la vulnerabilità del ceto medio e frenato le scelte virtuose delle famiglie.
Più che tagliare è quindi necessario aprire una nuova stagione di politiche sociali in grado di rinnovare e rilanciare, sostenendo, da un lato, le persone nei percorsi che alimentano il benessere personale e familiare, ma anche continuando, d’altro lato, a proteggere dal rischio di scivolare in spirali di progressivo impoverimento. In questi ultimi casi, come mostrano molti studi, se non si interviene per tempo si genera uno “svantaggio corrosivo” che va ad intaccare profondamente la capacità di reagire e risollevarsi.
Abbiamo quindi bisogno urgentemente di un nuovo welfare che metta al centro la persona, non prendendosi in carico passivamente dei bisogni ma supportandone sviluppo umano e inclusione sociale. I risultati migliori li ottengono, del resto, le politiche sociali che considerano i cittadini come persone responsabili e attive, in grado non solo di porre domande ma anche di contribuire a fornire risposte.
In sintesi, il nuovo welfare andrebbe incardinato su sei “p”. Tre riferite agli obiettivi da affidargli: proteggere chi sta peggio, prevenire dai rischi di peggioramento, ma anche promuovere lo star meglio. E tre “p” corrispondenti agli attori da mettere assieme in campo: oltre al pubblico, anche il privato sociale e la partecipazione dei cittadini. L’insieme di tutti questi fattori sta alla base di un welfare comunitario che stimola l’innovazione sociale sul territorio puntando a favorire coesione e capacità generativa delle comunità locali, a consolidare i legami di fiducia, a dar sostegno alla propensione alla condivisione e alla corresponsabilità verso il bene comune.
Nel suo recente Rapporto annuale l’Istat ritrae le nuove generazioni, quelle nate dagli anni Ottanta in poi, come vittime di un vecchio sistema di welfare che non funziona più. Dobbiamo invece sempre più pensare ad esse, per sensibilità e competenze, come principali protagoniste di un nuovo sistema sociale più in linea con le trasformazioni in corso e con le sfide dei tempi nuovi. Un welfare che metta assieme sia innovazione che inclusione, nel quale i cittadini siano allo stesso tempo destinatari e produttori di nuovo benessere. Parte centrale di un modello sociale e di sviluppo in cui nessuno, a partire dal pubblico, si deresponsabilizza, e che anzi incentiva tutti a fare un passo avanti, verso un futuro comune e condiviso