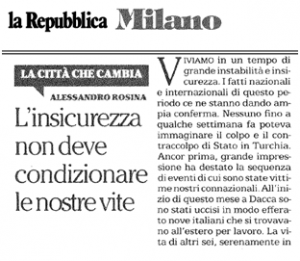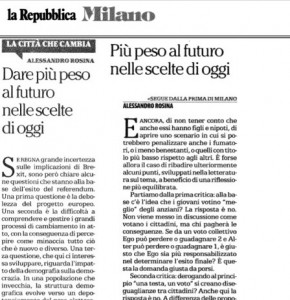E’ davvero strano che in Italia la natalità sia così bassa. Si tratta di un record negativo certamente sorprendente. Come mai da oltre un milione di nati negli anni Sessanta siamo precipitati oggi a meno della metà? Come mai nel corso degli anni Ottanta le nascite sono crollate di più in Italia che negli altri paesi sviluppati? Perché, a differenza di altri paesi, non siamo poi più riusciti a risollevarci? E, infine, perché la crisi ha frenato maggiormente le scelte riproduttive delle coppie italiane rispetto al resto d’Europa? Davvero un mistero il fatto che lungo tutto lo stivale non si formino nuove famiglie o ci si fermi al figlio unico. Eppure, come tutti riconoscono, siamo uno dei paesi che negli ultimi decenni hanno maggiormente incoraggiato l’autonomia dei giovani dalla famiglia di origine; che maggiormente hanno rafforzato una entrata solida e stabile delle nuove generazioni nel mercato del lavoro; che più valorizzano, con spazi e opportunità, il capitale umano dei neolaureati; che meno sfruttano e meglio pagano i neoassunti. Beh, se tutto questo fosse vero potremmo dire che abbiamo meno figli perché non li vogliamo. La realtà, purtroppo, è ben diversa e per nulla sorprendente. Siamo uno dei paesi con il record di giovani che vorrebbero lavorare e non ci riescono; con maggior ostacoli per le donne che vogliono sia lavorare che avere figli; con più alto rischio di povertà delle famiglie che vanno oltre il secondo figlio.
Il confronto con la Francia è istruttivo e impietoso. I dati di una comparazione internazionale del “Rapporto giovani” dell’Istituto Toniolo, svolta a luglio 2015, mostrano come tra gli under 30 il numero di figli che mediamente si vorrebbe avere, in assenza di vincoli e ostacoli nella realizzazione dei propri progetti di vita, è abbondantemente sopra a due. Se poi si passa a chiedere quanti bambini realisticamente si pensa di riuscire ad avere, il dato crolla a poco più di un figlio e mezzo in Italia, mentre scende a circa 1,8 in Francia. Ma il dato più interessante è che il numero di figli che poi effettivamente si riesce a realizzare risulta per gli italiani persino peggiore rispetto a quanto realisticamente dichiarato, mentre i francesi si trovano ad averne più di quanto preventivato tenendo conto di possibili difficoltà. Detto in altre parole, quello che accade da noi è che chi a vent’anni si vedeva in una famiglia con tre figli, si accontenta alla fine di averne due o solo uno. Chi puntava ad averne almeno uno si ritrova sempre più a posticipare fino a rinunciare del tutto. Anziché quindi trovarsi in un contesto che incoraggia a dare il meglio e a fare di più, ci si trova ad arretrare rispetto ai propri desideri e alle proprie potenzialità. In Francia, invece, grazie a politiche familiari più solide rispetto al bonus bebè, a un sistema fiscale non penalizzante per chi ha figli, a maggiori e più accessibili servizi di conciliazione tra lavoro e famiglia, a politiche attive per il lavoro più avanzate, ci si trova ad avere un figlio in più anziché in meno.
Non c’è solo la Francia. I paesi scandinavi hanno un modello diverso. Gli Stati Uniti un altro ancora. Il problema dell’Italia è che non ha un suo modello. Non esiste una bacchetta magica. Non c’è una soluzione unica valida per tutti. Ma ci sono due preoccupazioni cruciali che in altri paesi vengono prese più seriamente e affrontate con più decisione: offrire ai giovani maggiori strumenti di autonomia e maggiori occasioni di inserimento nel mondo del lavoro è una precondizione essenziale per formare nuove famiglie; consentire poi, alle nuove coppie, di andar oltre al primo figlio senza il rischio di dover rinunciare al lavoro di uno dei due, è fondamentale per non rinunciare ad averne altri. Su entrambi questi punti siamo da troppo tempo cronicamente carenti. Ma quello che non capiamo è che sciogliere questi nodi non significa solo fare più figli ed avere una demografia meno squilibrata, significa anche alimentare un modello di sviluppo nel quale giovani e donne organizzano meglio le loro vite, realizzano meglio i propri obiettivi, esprimono in pieno le loro potenzialità. Significa quindi avere una politica che sa mettere desideri e progetti dei cittadini al centro di una società ed una economia che funzionano.