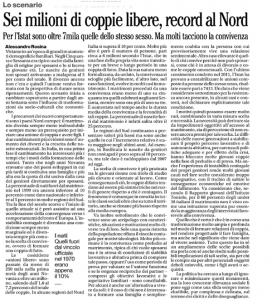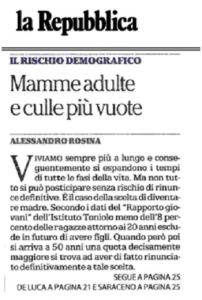
Viviamo sempre più a lungo e conseguentemente si espandono i tempi di tutte le fasi della vita. Ma non tutto si può posticipare senza rischio di rinunce definitive. E’ il caso della scelta di diventare madre. Secondo i dati del “Rapporto giovani” dell’istituto Toniolo meno dell’8 percento delle ragazze attorno ai 20 anni esclude in futuro di avere figli. Quando però poi si arriva a 50 anni una quota decisamente maggiore si trova ad aver di fatto rinunciato definitivamente a tale scelta. La percentuale, secondo le stime Istat, di donne mai diventate madri è salita da circa il 10 percento per la generazione del 1950 a oltre il 20 percento della generazione nata nel 1970.
Un motivo oggettivo sta nel fatto che nelle nuove generazioni Il tempo disponibile per avere figli si è ridotto all’interno di una fase della vita che si è, peraltro, notevolmente complicata. Sempre più ragazze, in misura anche maggiore rispetto ai maschi, estendono la propria formazione fino alla laurea. Il trovare un buon lavoro ha sostituito il trovare un buon partito nei motivi di indipendenza economica dai genitori. ‘L’instabilità dell’occupazione, assieme all’incertezza nelle relazioni affettive, porta sempre più oltre i 30 anni il momento in cui si inizia a mettere solide basi di una propria famiglia. Nel frattempo, però, il limite conclusivo del periodo fertile è rimasto pressoché immobile. L’età media alla menopausa è poco sopra i 50 anni, ma già dopo i 45 le possibilità di avere un figlio sono irrisorie. Avendo spostato tutto il percorso adulto dopo i 30, il momento riproduttivo centrale è diventato quello tra i 30 e i 34 anni, con una possibilità di recupero dopo i 35 che però diventa una strada in salita. I dati più recenti ci dicono che oggi una nascita su tre si realizza nella classe di età 30-34 e che la classe 35-39, con il 25% dei nati, supera quella tra i 25 e i 29 (23%). Questo vale ancor di più per le cittadine italiane che concentrano tra i 30 e i 39 anni quasi i due terzi nelle proprie nascite. Lo slittamento in avanti del punto di inizio della vita feconda, in combinazione con la rigidità del punto finale, ha quindi ristretto notevolmente lo spazio strategico di accesso all’esperienza della maternità. Nel contempo tale spazio si è anche riempito sempre di più di investimento lavorativo e professionale. Siamo così uno dei paesi avanzati in cui si arriva più tardi a cercare di avere un figlio ma anche, come ben noto, uno di quelli più carenti di strumenti per la conciliazione tra lavoro e famiglia. La conseguenza di tutto questo è che più facilmente ci si trova a rinunciare ad avere figli o a limitarsi ad un figlio solo.
Fino a qualche anno fa, tuttavia, la consistenza numerica delle trentenni era ampia e questo ha limitato la caduta della quantità complessiva di nascite nel Paese. Stiamo ora però entrando in una nuova fase, in cui le potenziali madri sono esse stesse in riduzione perché provengono dalle generazioni nate dopo il 1985, quanto la fecondità italiana è precipitata ai livelli tra i più bassi al mondo. L’Italia rischia quindi oggi di scivolare in una trappola demografica: meno figli ieri equivalgono a meno madri oggi e quindi ad ancor meno figli domani se le condizioni non cambiano.
Come uscire allora da questa trappola? Soprattutto togliendo le donne stesse dalla condizione di intrappolamento nella quale si sono sempre più trovate negli ultimi decenni e consentendo, in tempi meno tardivi e alla più alta espressione, la realizzazione delle loro scelte professionali e di vita. Più tardiamo ad agire in questa direzione più pesanti saranno i costi futuri.